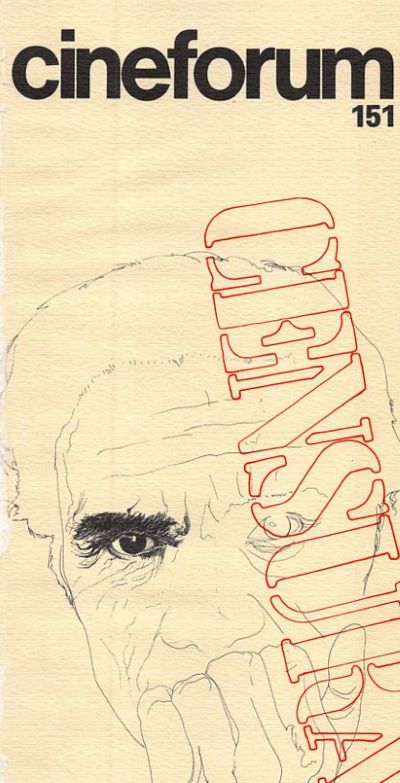Ganasce, ovvero i cinquant'anni di Lo squalo
Nel luglio di cinquant'anni fa, quasi a voler allietare scaramanticamente le vacanze balneari agli americani, usciva Lo squalo di Steven Spielberg. Opera seconda del regista (a parte Sugarland Express, Spielberg aveva però già fatto parecchia televisione, fra cui il notevole Duel e il pilot del Tenente Colombo), era tratta da un libro di Peter Benchley, che Fidel Castro aveva definito scherzosamente «una meravigliosa metafora della corruzione del sistema capitalistico». Battute fideliste a parte, Jaws (in italiano “fauci”, il titolo originale di libro e film) è un'opera già più che matura per un wunderkind quale era ancora all'epoca Spielberg, che sa fare tesoro della lezione hitchcockiana di creare una suspense perfetta facendo vedere il meno possibile. Vittorio Giacci ne parlò su «Cineforum» n. 151, gennaio-febbraio 1976, in una recensione che qui in parte riproponiamo.
«Cineforum» n. 151, gennaio-febbraio 1976
Lo squalo
Quando l'angoscia diventa profitto
Vittorio Giacci
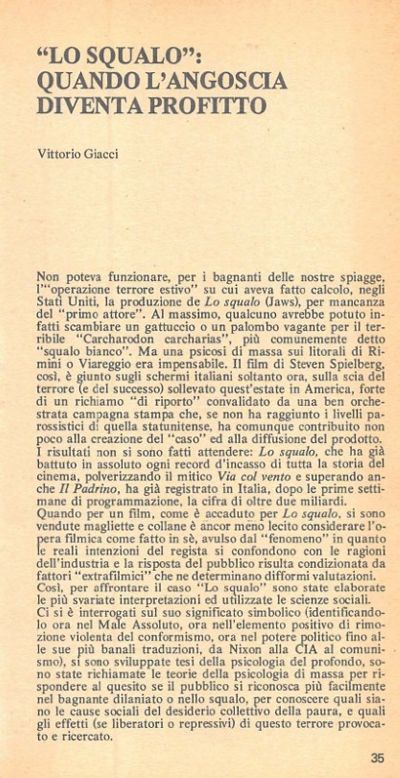 Non poteva funzionare, per i bagnanti delle nostre spiagge, l'“operazione terrore estivo” su cui aveva fatto calcolo, negli Stati Uniti, la produzione de Lo squalo (Jaws), per mancanza del “primo attore”. Al massimo, qualcuno avrebbe potuto infatti scambiare un gattuccio o un palombo vagante per il terribile “Carcharodon carcharias”, più comunemente detto “squalo bianco”. Ma una psicosi di massa sui litorali di Rimini o Viareggio era impensabile. Il film di Steven Spielberg, così, è giunto sugli schermi italiani soltanto ora, sulla scia del terrore (e del successo) sollevato quest'estate in America, forte di un richiamo “di riporto” convalidato da una ben orchestrata campagna stampa che, se non ha raggiunto i livelli parossistici di quella statunitense, ha comunque contribuito non poco alla creazione del “caso” e alla diffusione del prodotto. I risultati non si sono fatti attendere: Lo squalo, che ha già battuto in assoluto ogni record d'incasso di tutta la storia del cinema, polverizzando il mitico Via col vento e superando anche Il Padrino, ha già registrato in Italia, dopo le prime settimane di programmazione, la cifra di oltre due miliardi. Quando per un film, come è accaduto per Lo squalo, si sono vendute magliette e collane è ancor meno lecito considerare l'opera filmica come fatto in sè, avulso dal “fenomeno” in quanto le reali intenzioni del regista si confondono con le ragioni dell'industria e la risposta del pubblico risulta condizionata da fattori “extrafilmici” che ne determinano difformi valutazioni. Così, per affrontare il caso Lo squalo sono state elaborate le più svariate interpretazioni e utilizzate le scienze sociali.
Non poteva funzionare, per i bagnanti delle nostre spiagge, l'“operazione terrore estivo” su cui aveva fatto calcolo, negli Stati Uniti, la produzione de Lo squalo (Jaws), per mancanza del “primo attore”. Al massimo, qualcuno avrebbe potuto infatti scambiare un gattuccio o un palombo vagante per il terribile “Carcharodon carcharias”, più comunemente detto “squalo bianco”. Ma una psicosi di massa sui litorali di Rimini o Viareggio era impensabile. Il film di Steven Spielberg, così, è giunto sugli schermi italiani soltanto ora, sulla scia del terrore (e del successo) sollevato quest'estate in America, forte di un richiamo “di riporto” convalidato da una ben orchestrata campagna stampa che, se non ha raggiunto i livelli parossistici di quella statunitense, ha comunque contribuito non poco alla creazione del “caso” e alla diffusione del prodotto. I risultati non si sono fatti attendere: Lo squalo, che ha già battuto in assoluto ogni record d'incasso di tutta la storia del cinema, polverizzando il mitico Via col vento e superando anche Il Padrino, ha già registrato in Italia, dopo le prime settimane di programmazione, la cifra di oltre due miliardi. Quando per un film, come è accaduto per Lo squalo, si sono vendute magliette e collane è ancor meno lecito considerare l'opera filmica come fatto in sè, avulso dal “fenomeno” in quanto le reali intenzioni del regista si confondono con le ragioni dell'industria e la risposta del pubblico risulta condizionata da fattori “extrafilmici” che ne determinano difformi valutazioni. Così, per affrontare il caso Lo squalo sono state elaborate le più svariate interpretazioni e utilizzate le scienze sociali.
Ci si è interrogati sul suo significato simbolico (identificandolo ora nel Male Assoluto, ora nell'elemento positivo di rimozione violenta del conformismo, ora nel potere politico fino alle sue più banali traduzioni, da Nixon alla Cia al comunismo), si sono sviluppate tesi della psicologia del profondo, sono state richiamate le teorie della psicologia di massa per rispondere al quesito se il pubblico si riconosca più facilmente nel bagnante dilaniato o nello squalo, per conoscere quali siano le cause sociali del desiderio collettivo della paura, e quali gli effetti (se liberatori o repressivi) di questo terrore provocato e ricercato.
Senza nulla togliere alla validità di tali affermazioni, rese possibili dalla natura di “fenomeno di massa” del film, verrà ugualmente la pena però tentare di analizzarne struttura e senso specifici, tenuto conto anche della notevole personalità del regista, per vedere se, al di là del “fenomeno”, quest'opera meriti considerazione, e per evitare giudizi troppo facilmente “distorti”.
Va premesso che Lo squalo non è un epigono del filone “catastrofico” in via di rapida estinzione. Il terrore ricreato da film come Terremoto o L'inferno di cristallo si fondava su una superficiale emotività procurata, nel pubblico, dal sentirsi, collettivamente, in una situazione di estremo pericolo, teoricamente sempre possibile, mentre nello Squalo il senso di paura si rivolge (nella prima parte) all'“ombra ancestrale “di ciascuno, e trova risposta (nella seconda) nella lotta individuale tra l'animale e l'uomo, rappresentato in tre tipologie ben definite (il poliziotto, lo scienziato, il vecchio lupo di mare). Non è difficile individuare anche ne Lo Squalo il naturale sviluppo, pur se degradato ai livelli del compromesso commerciale, di una tematica personale che Spielberg aveva già espresso, con altra vigoria, in Duel e in Sugarland Express.
Alla base dei suoi film vi è infatti non il terrore ma l'angoscia, stato psichico più sottile e sconvolgente che nasce dalla concretizzazione di una situazione abnorme che perseguita l'uomo per procurarne la morte. Questa mostruosità emergente dall'inconscio, in Duel si identificava nel camion che inseguiva l'uomo per schiacciarlo; in Sugarland Express, in tono più polemicamente “politico”, coincideva con lo stesso sistema sociale e con il suo strumento più odioso, la polizia, che voleva soffocare la naturale richiesta di due giovani di rientrare in possesso del proprio bambino; ne Lo squalo, assume l'aspetto di un terrificante pescecane, emerso dalla profondità del mare, a portare una morte gratuita e terribile. In tutti i suoi film dunque, l'obbiettivo angoscioso è sempre la lotta contro la morte, una lotta assoluta, senza alternativa e preordinata fin dall'inizio verso un'unica conclusione.

La qualità migliore di Spielberg consiste nel tradurre le vicende in immagini metaforiche che rimandano a più significati possibili, e nel costruirli secondo una precisa bipolarità bene/male il cui conflitto ipotizza, per traslato, infiniti altri conflitti.
Questa bipolarità, comunque, non è antitetica ma speculare, come se fosse una monopolarità riflessa, una realtà che contempla l'aspetto mostruoso di sé: in Duel il camion era la creazione inconscia dello stesso David, la sua componente irrazionale, violenta e feroce riportata alla superficie da un esasperato processo di reificazione; in Sugarland Express il giovane braccato era identico al poliziotto preso in ostaggio, costituiva, nel “male” (dal punto di vista del “potere”) il suo “alter ego”, e la ricerca ostinata e senza speranza del figlio era la ricerca di se stesso e della propria identità; in Lo squalo (dove la metafora è più diluita), il pescecane è anche il riflesso simbolico della società del profitto la cui fame insaziabile si ritorce contro se stessa.
Il film di Spielberg si compone di due parti nettamente distinte che sembrano urtare contro le più elementari regole della continuità narrativa. In realtà questa frattura, oltre a essere un espediente psicologico che aggancia l'attenzione a una svolta risolutiva, ha un preciso significato che fa assumere al film una diversa dimensione rispetto a quella più evidente.
Nella prima parte il regista crea una situazione di angoscia generalizzata: lo squalo attacca e uccide senza che lo spettatore possa vederlo fisicamente (per tutta la prima ora di spettacolo) pur avvertendone (e proprio per questo motivo in maniera ancor più ansiosa) la minaccia, non appena la mdp indugi sullo specchio d'acqua o riprenda qualche bagnante che si immerge nelle onde, allo stesso modo con cui i bagnanti di Amity Bay (la cittadina dove si svolge la vicenda) si rendono progressivamente conto del pericolo che grava su di loro, ma ignorano il luogo e il momento dell'attacco. Spielberg in questa prima fase, con un procedimento di “suspense” crescente, stimola nella platea un fenomeno di psicosi collettiva, in perfetta sintonia con quanto avviene, sullo schermo, per la folla dei villeggianti.

Nella seconda parte si ha un mutamento della situazione emotiva perché si passa dalla minaccia oscura che viene dal mare (la prima sequenza del film, la più efficace, è una scena notturna, in cui la superficie marina risulta ancor più paurosa) alla caccia in mare aperto. I meccanismi di identificazione mutano radicalmente: nello spettatore scatta un altro tipo di angoscia, non più quella derivante dall'attacco dal profondo, ma quella più umana (e più rassicurante) del duello e del suo esito.
Istinto, scienza e autorità - Certo, la seconda parte è cinematograficamente più banale (come accade sempre quando si passa dall'elusività alla concretezza) con cadute nel grossolano e nel raccapricciante gratuito ma, se non si ci vuol fermare a una considerazione solo stilistica, si può riconoscere che le due sezioni del film non sono stridenti, ma necessariamente complementari, perché costituiscono sulla linea comune della rappresentazione dell'angoscia, un significativo spostamento dal “collettivo” all'“individuale” che rappresenta, a mio avviso, l'aspetto essenziale del film.
Nella prima parte infatti lo squalo è un'entità terribile anche perché·invisibile, le vittime appartengono alla folla dei bagnanti, una vale l'altra nella morte. Nella seconda, invece, l'attenzione si rivolge a tre soli personaggi, ognuno dei quali con una storia e un senso ben definito.
Il vecchio pescatore Quint che si offre di catturare lo squalo dietro un'alta ricompensa, in realtà cerca la sfida con l'animale per una ragione personale che nulla ha a che vedere con il vantaggio economico; Matt Hopper, il giovane oceanografo, è spinto all'impresa dalla curiosità scientifica, il che gli dà un distacco “oggettivo” dalla vicenda che contrasta duramente con la passionale animosità di Quint; Martin Brody, il capo della polizia locale, segue la missione più per dovere d'ufficio, ritrovandosi poi suo malgrado (ha avversione dell'acqua) a essere il vero vincitore del mostro. Il ruolo di questi personaggi è esplicito: Quint rappresenta l'esperienza e l'istinto, Hopper la fiducia entusiastica nella scienza e nella tecnologia da laboratorio non verificata nella prassi, Brody il buon senso comune, elemento prima di disturbo e confusione (si muove sgraziatamente sulla barca, procura guai agli altri che lavorano, l'uno con perfezionati strumenti tecnici, l'altro con la sola forza della sensibilità naturale) poi di sintesi vittoriosa tra i due poli teoria/prassi. La unione dei tre uomini nell'impresa è motivo di scontro tra ciò che essi rappresentano: istinto, scienza e autorità riproducono, nel microcosmo della barca sulla quale si combatte, i conflitti “interni” della società.

Gli sviluppi della vicenda sono rivelatori: dopo una prima caccia collettiva e “turistica” scatenata da barche e barchette giunte da ogni dove e che termina con la cattura di un piccoIo squalo ritenuto subito, nell'euforia generale, il colpevole degli assalti mortali, i tre, avuta la certezza che il pescecane è ancora libero nelle acque del mare, partono a bordo di uno squinternato peschereccio chiamato “Orca” (l'animale marino che attacca gli squali) alla ricerca solitaria del nemico. Non hanno nessuno dietro di sé, e poco prima dello scontro finale, Quint strappa i cavi della radio di bordo, per rendere ancor più estremo il loro isolamento. Questo atteggiamento suona inaccettabile se inteso realisticamente, perché è pericoloso, illogico e inutile, ma è ricco di significato simbolico rivelando l'essenza individualistica della lotta, la necessità atavica dello scontro-incontro personale con le forze della natura, come momento di vita contro la debolezza della massificazione. Non a caso il vincitore effettivo sarà proprio il meno convinto dei tre, il quale uscirà arricchito dall'avventura.
Anche se espressivamente fallimentare, ha un preciso senso la comparsa “fisica” dello squalo che, nella seconda parte del film, non è più un'ombra che scivola sott'acqua pronta a colpire, ma una concreta corporeità (ricostruita nella plastica) che si avventa, a fauci spalancate, contro la barca e i suoi occupanti. Tra l'intelligenza umana e quella animale si instaura un duello all'ultimo sangue dove i contendenti, come in Duel, si cercano e si inseguono a vicenda, l'uno necessario all'altro in termini di lotta, e che termina con la vittoria dell'uomo sullo squalo (dopo che questi ha divorato Quint, Brody lo farà letteralmente saltare in aria con una bombola d'aria compressa fattagli esplodere tra le mandibole) mentre Hopper, cacciatosi in un pericolo mortale per aver voluto sperimentare una trappola poco collaudata (una gabbia calata sul fondo del mare per colpire lo squalo a distanza ravvicinata con una punta avvelenata) si salverà per miracolo tornando a galla soltanto a lotta conclusa.

La struttura della vicenda rende quasi scontato il paragone con Moby Dick, anche se certamente il riferimento non va preso alla lettera, poiché il film non possiede assolutamente la dimensione “filosofica” del romanzo di Melville. L'accostamento con l'opera letteraria, e più in generale, con la “visione del mondo” del sistema intellettuale americano, consiste invece nella definizione comune del valore dell'individualismo come forma di conoscenza e di vita. In questo racconto sulla natura terribile che scatena i suoi mostri contro i quali, in una lotta isolata, l'uomo trova i mezzi per vincere anche là dove lo scontro sembra disperato, si ritrova infatti lo spirito indomito del solitario pioniere che domina la natura ostile, sorretto dalla sua forza e dall'ottimistica filosofia del pragmatismo, ideale costruzione mentale per un paese in espansione territoriale ed economica.
Oltre ogni altro (vero) discorso sull'angoscia, reazione psichica dell'uomo d'oggi, in questo ritrovato spirito delle origini può essere ricercato il senso primo del film, che infatti si svolge nel luogo deputato dell'avventura (lo spazio aperto “mare” invece dello spazio aperto “prateria” non modifica i termini del tema) sui modelli narrativi dell'inseguimento e della caccia, tra “pericolo” continuo e “fede” nella propria forza e ragione.
[...]