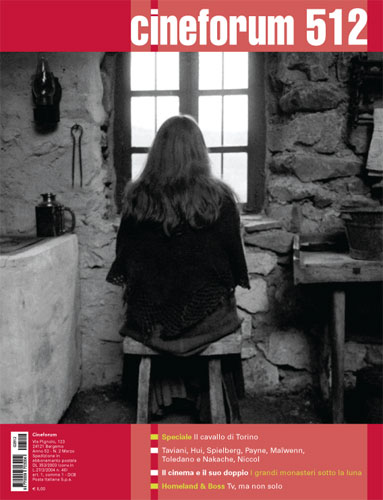Cesare deve morire
Questa sera, su Rai Movie, a partire dalle 21, una maratona dedicata ai fratelli Taviani, in ricordo di Vittorio, scomparso all'inizio della settimana. Di seguito l'uno all'altro verranno programmati: Cesare deve morire, Padre padrone e I sovversivi. Noi riproponiamo alcuni passaggi della recensione che Tullio Masoni scrisse sul primo film in programma, vincitore nel 2012 dell'Orso d'oro al Festival di Berlino. Il numero della rivista da cui è tratta la recensione è acquistabile qui.
--------------------------------------
Il film si apre sul palcoscenico ed è a colori. I primi piani, pur marcati, distraggono appena dall’impressione di una scena teatrale vista di fronte, dalla parte della platea. È teatro filmato, in qualche modo, ma credo sia un effetto volontario, cioè abbia una precisa funzione di contrasto.
Ritroviamo il colore alla fine, quando il palcoscenico torna davanti agli spettatori, e riprende l’azione (con qualche leggera variante) dove era stata lasciata dallo stacco del bianco e nero. Teatro “ufficiale” all’inizio, dunque, teatro “ufficiale” (o compiuto) alla fine, teatro “informe o provvisorio” nel lungo flash- back che meglio distingue il lavoro filmico e lo elegge a cuore dell’opera.
Ma perché il bianco e nero? Una prima risposta ci viene dagli stessi autori quando affermano che il colo- re è oggi così invasivo da essere diventato oggettività corrente, naturalistica. Un’altra potrebbe essere l’attribuire al bianco e nero una funzione di rovescio della superficie colorata o, anche, di disegno preparatorio del dipinto. Se, come accade in Cesare, l’abbozzo già usato dal pittore a scopo di studio assume piena centralità, possiamo pensare che la sua tecnica essenziale risponda a un’esigenza spiritualmente complessa; in altri termini, se il colore è naturalista, il bianco e nero serve meglio il reale, ove per reale si intenda l’approssimarsi poetico del vero.
Dal lungo flashback entro il quale la forma tragica si compie per brani provvisori, anomalia e contagio (il testo originario, la rappresentazione e le vita dei carcerati, la lingua tradotta e i dialetti) vorrei rilevare due momenti. Nel primo i detenuti scelti per le parti principali vengono presentati al pubblico con scritte in sovraimpressione: nome, reato, pena, mentre lo scarno e in certo modo struggente suono dell’armonica di un ergastolano funge da accompagnamento. È forse il primo vero soprassalto che il film provoca: il gioco dell’abitudine, consueto anche quando si assiste a uno spettacolo insolito, salta; da qui non possiamo più prescindere dalla “doppia vita” di Bruto, Cesare, Cassio, Marcantonio, e degli altri.
Il secondo momento è quello dell’esposizione del cadavere di Cesare e dei discorsi di Bruto e Marcantonio. Il corpo avvolto nella veste è a terra, al centro di un cortile troppo largo e piatto: attorno non c’è nessuno. O meglio, la folla che ascolta i discorsi preme dalle inferriate in alto: un popolo imprigionato come Bruto, Marcantonio e lo stesso Cesare sono.
Più volte, durante lo snodarsi del dramma, capita di subire un disorientamento; esso viene dagli scambi di ruolo, certo, ma è accentuato da un senso di costrizione (tutti nel carcere) che nella scena appena ricordata trova il suo acme.
[…] Se il Giulio Cesare è una tragedia della libertà, l’iniziativa dei Taviani di ambientarla in un carcere, e se non bastasse nel suo reparto di massima sicurezza, si dimostra illuminata come poche. Quando la catarsi dovrebbe “consolare” consolazione non c’è. E più ancora che il rientro forzato nelle celle dopo le prove e lo spettacolo in teatro, dove il trionfo fra gli applausi assume per un istante il tono dell’esasperazione plebea, grava il senso di ineluttabilità avviato con la ricordata presentazione degli attori-personaggi e i discorsi rivolti da Bruto e Marcantonio a una folla che di agita dietro le sbarre.
Al di là dei giusti intenti umanistici e umanitari, ossia dell’esaltazione del recupero anche nei casi più gravi di crimine compiuto, restano aperte le domande sul significato e la funzione del lavoro che i detenuti accettano di svolgere. In assenza della libertà essi riescono temporaneamente a ritrovarla attraverso l’arte, cioè nell’esercizio fantastico e al tempo stesso rigoroso della finzione. Ma non è solo questo: aderendo all’angoscia di Bruto, che non può dare confini certi alla propria infelicità, essi coltivano nella finzione stessa – è uno dei Taviani a testimoniarlo – la speranza di accedere, solo e ancora per il tempo limitato del fare scenico, a un perdono altrimenti impossibile.