Povero re, povera la regina e povero anche il cavaliere
Cinquant'anni fa veniva presentato a Cannes, e subito dopo distribuito in Italia, Lancillotto e Ginevra di Robert Bresson. Il regista francese rilegge le gesta narrate nel Ciclo arturiano riducendole agli elementi essenziali: scremato ogni elemento fantastico (di Merlino non c'è traccia), il Lancelot bressoniano si muove in un mondo caratterizzato dal male, dalla violenza, in cui le regole, in primis quelle della cavalleria altrove celebrate, sono costringimenti soffocanti come le armature dei cavalieri stessi (notevole è il lavoro sul suono, con il costante, ossessivo sferragliare delle corazze). Comprese le regole dell'amor cortese: come ebbe a dichiarare Bresson, «La quête du Graal, c'est l'amour de Dieu d'un côté et de l'autre l'amour profane, c'est un peu cette opposition que j'ai retenue». Di tutto ciò ne scrisse con il consueto, acuto spirito di approfondimento Ermanno Comuzio su «Cineforum» n. 134, luglio 1974, in un'ampia scheda di cui proponiamo un estratto.
«Cineforum» n. 134, luglio 1974
Scheda Lancillotto e Ginevra
La cavalleria secondo Bresson: fantocci dentro le armature
Ermanno Comuzio
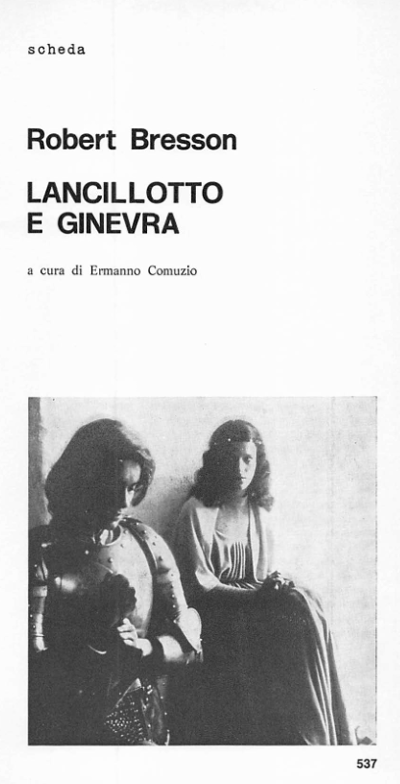 Leggenda, mito, letteratura. Cosa ha preso Bresson del ciclo bretone? Lancillotto, guerriero invitto, difensore della fede, amatore squisito, prototipo della cavalleria, cosa dice a Bresson? È chiaro che questo autore non si accontenta dell'epos così com'è tramandato attraverso i secoli, cristallizzato in una esaltazione favolistica dei valori “puri” (l'eroismo, la fede, l'amore, appunto), ma che sottopone questi valori a una revisione. Per cominciare, Lancillotto è fedele (al suo re, come suddito) e infedele (come amante della regina) al tempo stesso, ma se nella leggenda questa sua doppiezza è accettata e difesa come atteggiamento perfetto di gentiluomo cortigiano (secondo il codice “cortese” il tradimento coniugale veniva accettato a patto che fosse mantenuto entro forme perfette), in Bresson questa posizione viene sentita in tutta la sua ambiguità. Per non dire della fedeltà-infedeltà di Lancillotto rispetto alla religione e, quel che più conta, rispetto alla verità e alla giustizia.
Leggenda, mito, letteratura. Cosa ha preso Bresson del ciclo bretone? Lancillotto, guerriero invitto, difensore della fede, amatore squisito, prototipo della cavalleria, cosa dice a Bresson? È chiaro che questo autore non si accontenta dell'epos così com'è tramandato attraverso i secoli, cristallizzato in una esaltazione favolistica dei valori “puri” (l'eroismo, la fede, l'amore, appunto), ma che sottopone questi valori a una revisione. Per cominciare, Lancillotto è fedele (al suo re, come suddito) e infedele (come amante della regina) al tempo stesso, ma se nella leggenda questa sua doppiezza è accettata e difesa come atteggiamento perfetto di gentiluomo cortigiano (secondo il codice “cortese” il tradimento coniugale veniva accettato a patto che fosse mantenuto entro forme perfette), in Bresson questa posizione viene sentita in tutta la sua ambiguità. Per non dire della fedeltà-infedeltà di Lancillotto rispetto alla religione e, quel che più conta, rispetto alla verità e alla giustizia.
Il film non è facile, tutto allusivo e sincopato com'è, e spesso è ambiguo. L'impostazione, comunque, è inequivocabile. La ricerca del Graal (anzi: la conquista del Graal, più che ricerca) non è più quell'allegoria della ricerca di Dio che era nel mito originario, ma un feroce esercizio di potere, per il quale ogni ostacolo – beni, vite umane, diritti – deve venir tolto di mezzo. Il sangue cola a fiumi, per mettere le mani sul simulacro portentoso, simbolo di supremazia, segno di enorme prestigio, chiave per ottenere troni ed eserciti. Si continuano a chiamare le cose con i loro nomi “spirituali” (si parla di Dio, di pietà cristiana, si prega spesso, si esaltano gli ideali) ma l'originale tensione religiosa è completamente travisata. Come nel Processo di Giovanna d'Arco, la Chiesa esercita una mediazione infedele tra le spinte verso la conoscenza dell'Assoluto e l'attuazione pratica di tale ricerca attraverso i suoi ministri e i suoi difensori.
I cavalieri continuano a dire di cercare Dio, e credono a quel che dicono, ma è la loro idea di Dio a essere sbagliata. Lo rinfaccia Ginevra a Lanoillotto: «Non volevate il Graal, volevate Dio. Ma Dio non è un oggetto che si trasporta». Un Dio mercificato, quello dei cavalieri di Artù, un Dio utilitaristico, strumento per dominare·i più deboli, in nome del quale («Gott mit uns») incendiare, uccidere. «Quanto sangue versato!» è una frase leit-motiv, che torna diverse volte nel film quando qualcuno (Artù, Ginevra, lo stesso Lancillotto) si riferisce alla “spedizione di conquista” del Graal (e il concetto è fin troppo dichiarato, visto che ne è già chiarissimo il senso nel fulmineo proemio – le immagini della violenza bruta scatenata in nome di Dio – cui fa corona la sequenza finale del massacro di Lancillotto e dei suoi).
Il film è dominato da cima a fondo da questa dicotomia fra l'astrattezza di compiti sublimi e la tragica colpevolezza dei comportamenti: tutto·il senso dell'epopea cavalleresca ne viene travolto. «Tutte le avventure di questi cavalieri vagabondi sono, in fondo, momenti di una ricerca dell'ideale la cui conclusione sarà, insieme, la conclusione dei tempi avventurosi: simbolicamente questo significa che il Graal, forma poetica del messaggio cristiano giunto nel Nord, porrà termine, col suo apparire, all'antica tradizione pagana di magia e di lotta per stabilire il regno dell'elevazione spirituale, della Grazia e dell'amore». Così Ugo Déttore definisce il significato della cavalleria secondo il ciclo bretone. Ma nel film il “messaggio cristiano” è tale soltanto per comodo, e in quanto tale non raggiunge né lo spirito, né la Grazia, né l'amore.
Lancillotto e gli altri cavalieri di Artù sono essi stessi dei simulacri. La loro disumanità sostanziale, sotto le belle armature, sotto il loro aspetto nobile e terribile, è la loro caratteristica principale. Essi sono monumenti a se stessi, rinchiusi nelle corazze come in impalcature che fanno loro da sostegno e che condizionano i loro movimenti, ma è come il guscio di un crostaceo morto, dentro non c'è niente, è tutta apparenza.
Il rumore di ferraglia domina la pellicola in maniera ossessiva: ogni più piccolo spostamento dei personaggi implica uno sforzo innaturale, ripercosso nel sonoro. Lo stesso senso hanno i continui scatti delle visiere che si alzano e si abbassano, a nascondere il viso di chi è sepolto dentro la struttura d'acciaio; le rare volte in cui qualcuno si spoglia della sua armatura (sono i momenti – davanti a Ginevra, quando Lancillotto è in pericolo di vita – in cui l'uomo è protagonista, non il guerriero) i pezzi cascano a terra pesantemente, come rottami. Le zampe dei cavalli, i nitriti dei cavalli, il galoppo dei cavalli privi di cavaliere, e che pure continuano insensate corse, prolungando assurdamente cariche e fughe, sono altri elementi eloquenti della disumanità dei cavalieri e delle loro gesta, che Bresson fa diventare stile.

Eccoci soprattutto allo stupendo finale·in cui Lancillotto, ferito a morte, cade sul mucchio degli altri guerrieri già morti (una corona ci dice che fra questi è anche Artù, ma niente differenzia quel mucchio di ferro dagli altri). Sono ormai dei fantocci inanimati, avanzi di cose rotte e buttate, vero e proprio “cimitero delle macchine”. Altro·che «Bronzo nel bronzo, nell'arcion s'incastra», come declama il D'Annunzio a proposito della statua equestre di un condottiero in armatura!
Dio non domanda che si rinunci all'amore: Ginevra strumento della Grazia
Invece di raggiungere la Grazia e l'amore, Lancillotto trova la morte, ingloriosa, solitaria, priva di ogni leggendaria risonanza. Egli non ha capito niente né dell'una né dell'altra cosa. Non capisce il valore del suo amore per Ginevra, né la portata di quello di Ginevra per lui, e attribuisce a Dio la sua incapacità: così tradisce la Grazia e l'amore. «Ho visto il Graal», si giustifica «Una voce mi accusò di doppiezza, di viltà», e ancora: «Dio mi ha imposto di sciogliermi dal giuramento», al che Ginevra ribatte: «Dio non può sciogliere un giuramento che hai fatto a me».
Ecco, il discorso sul rapporto fra potere e amore, tipico di Bresson, prende qui l'aspetto di una meditazione piuttosto sottile – siamo nell'occhio del ciclone – sulla equivalenza tra Grazia e amore. Lancillotto è cieco, non si rende conto che la Grazia di Dio risiede non nella guerra di conquista «nel nome di Dio», ma nella perfezione dell'amore; Ginevra invece ne ha la lucida consapevolezza. Bresson cambia la natura dei personaggi del ciclo letterario: di Lancillotto toglie la parte relativa al suo invecchiamento in un eremitaggio e nega la sua capacità di obliarsi nell'amore (come è nel più alto autore del ciclo, Chrétien de Troyes), e di Ginevra non conserva la natura mondana, che vede nell'adulterio un elemento capace di intensificare il fascino della grande avventura amorosa, ma – avvicinandola a Isotta, personaggio dello stesso ciclo – ne fa una donna che si impegna con tutta se stessa nel sentimento che la nutre. Come il rigattiere-usuraio di Une femme douce, Lancillotto è attaccato ai “valori solidi”, alle regole e ai rispetti umani, è un uomo arido. Rappresenta tanto bene il suo ruolo di “eroe” e di “santo” da indurre in equivoco chi lo conosce dal di fuori: Gauvain dice di lui: «Lancillotto diventerà un santo. Lo vedremo sul calendario», e la ragazzina, figlia della vecchia del bosco, bacia per terra le orme del cavallo su cui Lancillotto, guarito delle sue ferite, abbandona la casupola.
Ma quanto è lontano dall'eroismo e dalla santità! Non si tratta di un·ipocrita, sia chiaro; la questione è più sottile. Egli crede a quel che fa, ne è convinto: per una certa Chiesa gerarchizzata potrebbe benissimo essere fatto santo. Ma i suoi equivoci sono di una meschinità paurosa: Dio mi ha detto questo, Dio mi ha imposto quest'altro. Non capisce niente della fede, quando se ne fa·avallo per isterilire il rapporto sublimante dell'amore, e·il suo autoerigersi a eletto di Dio e suo confidente è un atto di orgoglio. Alle colpe derivanti dalla sua vana violenza nella lotta per il Graal aggiunge ora non quella di sentirsi responsabile di quanto ha fatto – tutti, nella pellicola, hanno un pesante senso di colpa – ma quella di paralizzare i sentimenti e di guastare l'esistenza sua e altrui sentendosi “investito” da Dio di compiti riparatori. «È orgoglio, credersi responsabili di tutto. È orgoglio, non umiltà», gli dice Ginevra.
Ginevra sa vedere l'essenza delle cose. «Dio non domanda che si rinunci all'amore», dice nel primo bellissimo colloquio nel “buen retiro” del bosco. «No, non rinuncerò a questo prezzo». Prima che ceda per ubbidienza, perché nonostante tutto si sente parte della volontà di lui, ella lotta con dolce ma decisa determinazione: «È inutile che io mi sacrifichi», è inutile, cioè, che si voglia salvare l'universo quando qui vicino, dentro di noi, è la salvezza. L'“egoismo” di Ginevra contrasta sanamente con la vaniloquenza di Lancillotto, il quale coltiva valori astratti, principi etici assunti nella loro veste esteriore, sclerotizzati in una morale comportamentistica e “ufficiale” che tradisce la vera ricerca dell'Assoluto.

Questo è il vero tradimento di Lancillotto. L'amore di Ginevra è la ragione vitale, il respiro, l'esistenza. «Il mondo è grande quando ci sei tu. Tu sei l'infinito». E ancora: «Anche il corpo senza di te muore». Il corpo, non solo lo spirito, poiché anche di corpi siamo fatti. Ginevra dice queste cose molto intense con semplicità, anzi con freddezza, secondo il noto stile bressoniano dell'understatement, per cui i suoi personaggi (e dunque i suoi attori) devono enunciare, e non esprimere, in modo che il significato di quel che dicono venga fuori da solo, senza intermediazioni, più puro.
Inutile invocare Dio se non si mette in pratica il Suo messaggio
«Quello che importa non è quello che l'attore rivela, ma quello che nasconde», ha detto una volta Bresson. Di qui l'uso di attori non professionisti, digiuni di ogni tecnica. Il procedimento è pericoloso, si capisce, e non tutti possono adottarlo·impunemente; è indubbio comunque che con questo regista questa donnetta bionda e chiusa, così bella così dolce, pulita, con gli occhi azzurri di una semplicità e di una sincerità che mettono in imbarazzo, persino, con le sue vesti grigio-cenere, rosa o azzurro pallido, i suoi gesti misurati, la sua riservatezza, fa di Ginevra una creatura dalle passioni tese, dalla grande dignità e dai sentimenti profondi.
La cecità di Lancillotto risiede nel non capire che la fede è qui, nell'amore, che qui è la Grazia. «Resta la fede che ci siamo scambiati, la promessa», lo rimprovera lei, ma lui si è tolto la “fede” dal dito e ha rinengato la promessa. Crede di servire Dio, facendo così, e invece lo tradisce, tradendo l'amore. «Dio non si ottiene rabbiosamente, si dona attraverso l'amore», dice ancora Ginevra, e gli rimprovera quella che alle sue orecchie è la più grossa bestemmia di lui, la distruzione volontaria dell'amore: «Non si supplica per non essere amati».
Quando non è più possibile l'amore, quando non c'è più la Grazia, c'è la sconfitta e la morte. I cavalieri tornano a mani vuote, dalla ricerca del Graal, «umiliati e sgomenti» dalle violenze provocate e subite, e Lancillotto, oltre a ciò, rifiuta la salvezza che gli viene offerta: sono due momenti dello stesso fenomeno, il rinnegamento dell'amore, cui segue il cadere in disgrazia. «Avete ucciso, saccheggiato, distrutto. È per amore, che avete fatto questo?», dice Ginevra, e il concetto è fin troppo sottolineato. Il contrasto tra il conclamato amore di Dio e, in pratica, la negazione dell'amore di Dio (dell'amore / di Dio) è il fulcro del film, e non appartiene solo alle vicende dell'anno Mille.
Il discorso di Bresson appartiere all'oggi. Inutile invocare Dio mentre non si raccoglie il suo messaggio, inutile aggrapparsi alle formule istituzionali se non si agisce secondo lo spirito evangelico. A chi gli domanda cosa fare, re Artù esorta: «Attendiamo che Dio ci faccia la grazia di ispirarci» (che fa tanto «San Gennaro pensateci vui, facite 'a grazia») e poi ancora, a Gauvain impaziente («Vorrei fare qualcosa. Datemi un compito») risponde: «Te l'ho dato un compito. Prega». Il commento dello stesso Lancillotto è rivelatore della necessità di agire, di compromettersi in proprio senza demandare tutto a un Dio di comodo: «Vorrei aver imparato cose più utili».
E infatti Lancillotto tenterà di riconquistare la Grazia, di passare all'azione. In un primo tempo parteciperà al torneo, per umiliare i nemici di Ginevra. Quando si arma per il torneo si mette al dito anche l'anello di Ginevra, e tutto il suo atteggiamento è di preghiera: l'azione è qui vista come atto d'amore e come preghiera. Ma la sua vittoria è pagata a duro prezzo: il peccato commesso provoca la rovina sua e di Ginevra, anche se egli tenta di toglierla dalla prigione del re; il fatto è che non è più capace di vera fede. La discordia tra cavalieri – addirittura tra fratelli – continuerà, Lancillotto ucciderà il suo miglior amico, il re verrà tradito, la morte squallida li cancellerà dalla terra.
La perdita della Grazia equivale alla sconfitta, alla morte. Una morte è, per Ginevra, il consegnarsi nelle mani del re; quella di Lancillotto non è soltanto il distacco dell'anima dal corpo, ma la morte degli ideali, la sconfitta dell'umano. La conclusione di Bresson è amarissima, la più triste di tutti i suoi film, ed è in rapporto evidente con la situazione attuale dell'uomo, sopraffatto da falsi valori, obnubilato dalle parole bugiarde, condannato all'autodistruzione per colpa della violenza, della cecità e dell'ignoranza.

