Pasolini cineasta e romanziere cinquant’anni dopo
Il 2 novembre di esattamente mezzo secolo fa veniva ucciso Pier Paolo Pasolini. Intellettuale a tutto tondo, poeta, scrittore, linguista, cineasta, intelligentissimo polemista e attentissimo osservatore della società contemporanea (e dell’evolversi del nostro Paese), è persino superfluo dire quanto ci manchi, e ci manca tanto, la sua finissima lucidità di artista e uomo di cultura. Al momento della sua morte, Pasolini fra le altre cose stava lavorando a Petrolio, un romanzo rimasto incompiuto e pubblicato postumo. Alessia Ugolotti ne analizzò il taglio fortemente “cinematografico”, in un saggio vincitore del Premio Adelio Ferrero pubblicato poi su «Cineforum» n. 355, giugno 1996, di cui riproponiamo un ampio brano.
«Cineforum» n. 355, giugno 1996
Petrolio
La sintesi del cinema di Pier Paolo Pasolini
Alessia Ugolotti
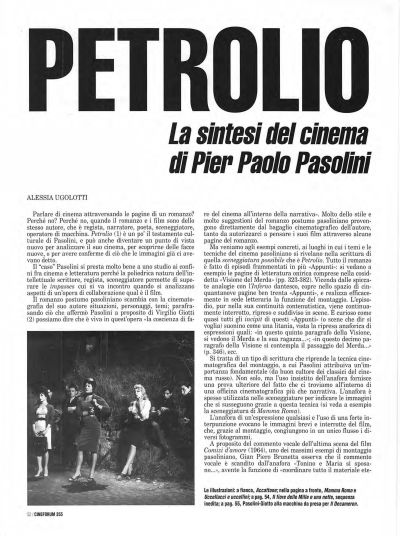 […] Petrolio ci parla di cinema, perché parla come il cinema, talvolta con le stesse figure retoriche. Leggiamo nella sezione prefatoria: «Per riempire le vaste lacune del libro, e per informazione del lettore, verrà adoperato un enorme quantitativo di documenti storici che hanno attinenza coi fatti del libro: specialmente per quel che riguarda la politica e, ancor più, i fatti dell'Eni. Tali documenti sono: giornalistici (reportage di rotocalchi, “l'Espresso”, eccetera) e in tal caso sono citati per intero; testimonianze orali “registrate”, per interviste eccetera, di alti personaggi o comunque di testimoni; documentari cinematografici rari».
[…] Petrolio ci parla di cinema, perché parla come il cinema, talvolta con le stesse figure retoriche. Leggiamo nella sezione prefatoria: «Per riempire le vaste lacune del libro, e per informazione del lettore, verrà adoperato un enorme quantitativo di documenti storici che hanno attinenza coi fatti del libro: specialmente per quel che riguarda la politica e, ancor più, i fatti dell'Eni. Tali documenti sono: giornalistici (reportage di rotocalchi, “l'Espresso”, eccetera) e in tal caso sono citati per intero; testimonianze orali “registrate”, per interviste eccetera, di alti personaggi o comunque di testimoni; documentari cinematografici rari».
Il brano denuncia la tendenza al documentarismo che è propria del cinema pasoliniano, di cui non può fare a meno nemmeno l'espressione letteraria. Ma la parola è sempre un simbolo e come tale è indiretto. Solo la rappresentazione cinematografica della realtà è fedele alla realtà stessa. E qui è richiamata l'esperienza dell'autore documentarista (Comizi d'amore) e dell'autore di film “di montaggio” (La rabbia). Quest'ultimo film propone una summa della realtà sociopolitica dei primi anni 60. Lo stesso rappresenta Petrolio per la realtà postsessantottesca, con la differenza che il documentario (in questo caso verbale scritto) risulta romanzato attraverso l'inserto della vicenda del personaggio romanzesco Carlo Valletti.
Petrolio è insomma una sceneggiatura di un nuovo Salò? Può essere. Sottoscriviamo in pieno le osservazioni avanzate da Stefano Agosti, secondo cui Petrolio è costituito da una serie di appunti per un'eventuale trascrizione visiva, come la sceneggiatura di un film.
Il lettore di Petrolio troverà cosparsi nel testo gli scenari del cinema pasoliniano, non solo per identità di soggetti, ma anche perché la descrizione paesaggistica è talvolta trattata come fosse una scenografia, un pezzo di mondo ritagliato al fine di costituire la quinta scenica di una sorta di “sacra rappresentazione”. Consideriamo, fra tutti, questo brano: «[Carlo] si guardava intorno per scegliere il posto adatto. Ma qui c'erano troppe buche e piccoli “montarozzi” scoscesi […]. La distesa irregolare e immensa del prato con in fondo le sue barriere di case coi lumi tremolanti (palazzoni da una parte, una distesa di casette dentellate coi muri a secco dall'altra); il cielo con qualche nuvola spennellata appena nel suo indaco profondo; la luna, in mezzo a quel cielo, che da rossa stava diventando di una luce fresca e purissima, con accanto, altrettanto luminosa la fedele piccola stella del crepuscolo. Tutto questo scenario – dove non c'erano sfumature, se non forse ai bordi del tratto fosforescente di cielo illuminato dalla luna – era riempito da un unico profondo odore, quello del finocchio selvatico. Tutto il cosmo era lì, in quel pratone, in quel cielo, in quegli orizzonti urbani appena visibili e in quell'inebriante odore di erba estiva».
È il prato il protagonista indiscusso della “scenografia”, costruita ad arte per ospitare determinate scene. Il motivo è presente in maniera ossessiva in Petrolio (Il pratone della Casilina è il titolo di uno dei brani più scabrosi del romanzo, messo in scena da Giuseppe Bertolucci nel cortometraggio Il pratone del Casilino), ma anche nelle poesie e nella cinematografia pasoliniane, sempre come “luogo sacro” deputato al commercio degli amplessi; pensiamo al “notturno” di Accattone, l'episodio in cui viene aggredita la prostituta Maddalena (Silvana Corsini), una scena circondata dalla città indifferente, lontana: ecco un altro topos pasoliniano (si pensi alla scena della “Passione” di Stracci nel mediometraggio La ricotta del 1964). Analoghe situazioni si riscontrano nella bertolucciana Commare secca (1962), dove proprio la scenografia svela la presenza di quel «pasolinismo senza Pasolini» attribuito comunemente al film.

Tra le tecniche predilette dal Pasolini regista spiccano le “carrellate”. Si pensi ad alcune scene di Mamma Roma, Accattone, e alle scene coi deambulanti Totò e Ninetto Davoli di Uccellacci e uccellini. Nel caso di quest'ultimo film la carrellata precede un andare avanti che costituisce il perno di tutta l'opera. In una glossa riportata tra le ultime pagine di Petrolio, viene descritta una discesa agli inferi di Carlo sognata dall’autore durante una notte. Verso la fine si legge: «Carrellata indietro per cui Carlo è spettatore delle imprese dell'eroe mitico [il centauro]».
L'autore introduce la tecnica della “carrellata” in una narrazione verbale-scritta, tanto che il punto di vista del protagonista è ricondotto a una immaginaria macchina da presa che si muove in “carrellata” seguendo gli oggetti e i personaggi, mantenendo da essi una distanza costante. L'osservatore e i fatti sono sempre equidistanti, i loro spazi sono definiti e incompatibili, come gli spazi (opposti) in cui si muovono l'attore e il regista. Qui, in particolare, si tratta di un carrello “a precedere”, in quanto Carlo (nei panni di un probabile regista) avanza a ritroso.
La traslazione in sede letteraria della tecnica della carrellata fa sì che il punto di vista del lettore risulti distaccato e contemplativo; un punto di vista subordinato all'oggetto e ai suoi movimenti. La contemplazione è passiva, sottomessa; è l'oggetto, non il soggetto a guidare la percezione. La frontalità tipica dello stile filmico pasoliniano non viene compromessa dal movimento dei personaggi: l'obiettivo della macchina da presa è sempre perpendicolare alla direzione del «muto camminare chapliniano della vita» (Rinaldo Rinaldi), caratteristico di tanti personaggi cinematografici e letterari pasoliniani. La frontalità sembra diventare un valore assoluto anche della pagina scritta.
Nel tessuto narrativo di Petrolio si nota una quasi totale assenza di dialogo, cosa che allontanerebbe il testo da ogni pretesa di sintesi cinematografica. Ma vista da una prospettiva più globale (ecco che cinema e narrativa si spiegano reciprocamente) la carenza del dialogo fa parte di una certa inclinazione al silenzio del cinema pasoliniano, a partire da Il Vangelo secondo Matteo.
Questa caratteristica del romanzo ricorda certe scene interminabili dei film sospese nel silenzio, o meglio, nell'assenza di parole. Si pensi ai silenzi stagnanti vicini all'Antonioni “esistenzialista” di Teorema, alle lunghe sequenze di Medea e di Edipo re dove “parla” solo la musica dei canti popolari. Si riscontrano atmosfere analoghe in Il silenzio di Ingmar Bergman, dove – come ha detto bene Arbasino – «Ci sono più metafore che nei Lirici Marinisti». L'affermazione vale anche per Teorema, «in cui ogni cosa significa un'altra cosa» (Pasolini). Ed è anche questa connotazione allegorica che accomuna il film a Petrolio, romanzo generoso di “silenzi cinematografici”: certe azioni sembrano svolgersi in un mutismo, in una sospensione carica di sacralità (e di grottesco). Questo si avverte, a esempio, nell'episodio della visita di Carlo alla famiglia nel torinese, quando in un'atmosfera sospesa e silente “a turno” egli ha rapporti incestuosi con tutti i membri della famiglia, uno dopo l'altro, madre compresa. Un po’ come l'Ospite di Teorema.
C'è un altro aspetto che mette in relazione la carenza di dialogo del romanzo coi film di Pasolini. L'autore sembra preferire al dialogo la messa in risalto della gestualità e della mimica. Si antepone cioè al linguaggio verbale, il linguaggio polisemico della realtà di cui, per Pasolini, il cinema costituisce la messa per iscritto. Solo rari frammenti dialogici si ritrovano nell'episodio del Pratone della Casilina. «La lunga scena», osserva Gilbert Bosetti «che descrive minutamente la gestualità e i corpi dei venti giovani […] si svolge quasi in silenzio ed è prevalentemente cinematografica».
Il cinema è presente in filigrana in un testo così coloristico e visivo anche nel suo aspetto di arte figurativa, fondamentale per Pasolini, grande visionario e grande creatore di immagini; mettore in immagine – se si potesse dire –, prima che regista. La “fotografia” di Petrolio, che contempla una luce intensa, meridiana, sgranata ha molte affinità con quella dei racconti raccolti in Alì dagli occhi azzurri e con quella del primo film di Pasolini. In Accattone questo taglio della fotografia serve a immergere la vicenda dell'eroe preborghese in una dimensione mitica.
Tanti incipit di scena della sceneggiatura di Accattone mettono in risalto immediatamente l'arsura, il caldo che crea un'atmosfera analoga a quella della “fotografia” di Petrolio. La luce solare ha una connotazione di violenza: sfolgorante e accecante, sembra voler inferire – per dirla con Zigaina – uno «sfregio espressionistico» al quadro di insieme. Anche Petrolio, come le poesie, trabocca di luce estiva e, come le sceneggiature, tiene a dare una certa priorità alla descrizione fotografica e luministica, riservando a essa diversi incipit di sezioni.
Petrolio è inoltre un romanzo “girato in Technicolor”; in esso non solo le tinte sono sempre accuratamente specificate, ma assumono anche dei connotati di forte espressività. In questo senso il romanzo è più vicino alla cinematografia a colori di Pasolini e al Technicolor, che sostituì a partire da Che cosa sono le nuvole? (1967) il bianco e nero dei film precedenti. Un indefinito magma di ocre e rosa, a esempio, accompagna molte scene di Petrolio in quell'atmosfera che il regista definiva sul set di Edipo re «barbarico indistinto». Questi paesaggi ricordano le atmosfere di quell'«onirico plein air» (un felice risultato della combinazione di paesaggi asiatici e africani) del Fiore delle Mille e una notte; e ricorda anche le immagini di Edipo re nel blocco centrale (distinto da prologo ed epilogo nei quali domina il verde).

La virtuale macchina da presa dello scrittore indugia spesso sui caratteri fisici dei personaggi, con una inclinazione particolare per i volti. La stessa predilezione è dimostrata nei film, dove il “primo” o “primissimo piano” del personaggio anonimo assurge a vero e proprio topos stilistico. Si pensi, fra i tanti, ai visi sdentati ed espressivi delle comparse nel Fiore delle Mille e una notte. In particolare i ricci, la bocca tumida, gli occhi scuri, il naso sottile sono le caratteristiche fisionomiche dell'interprete scelto per il sorridente Nur ed Din, protagonista della novella centrale che irradia tutte le altre del Fiore delle Mille e una notte. «Attribuisco una grande importanza ai visi», interviene l'autore «anche perché con essi è impossibile barare: la cinepresa rivela la loro realtà più intima». Si tratta di una dichiarazione di poetica, in cui Pasolini allude al cinema nella sua accezione di “lingua scritta della realtà”. «Quando giro un film», continua l'autore «mi immergo in uno stato di fascinazione davanti a un oggetto, a una cosa, un viso, gli sguardi, un paesaggio, come se si trattasse di un congegno in cui stesse per esplodere il sacro».
Pasolini cede anche nel romanzo postumo al vizio e al vezzo della citazione pittorica, di quella pittura più vicina e congeniale al gusto figurativo e compositivo dello scrittore: si tratta di allusioni a impianti figurativi che il regista Pasolini dice di avere «in testa come visioni». In un brano fra i più visionari del romanzo, l'autore si serve di un'immagine di Giotto, con ogni probabilità – ma non è esplicito nel testo – quello dell'affresco padovano La cattura di Cristo. In particolare, si verifichi la fissità e l'attenzione degli sguardi che Cristo e Giuda si scambiano nell'affresco della Cappella Scrovegni col brano di romanzo relativo. Non è certo il primo incontro fra l'immaginario pasoliniano e gli affreschi giotteschi: si ricordi il tableau vivant sognato dall'Allievo di Giotto-Pasolini nel Decameron, certamente ispirato al Giudizio Universale giottesco. Alla luce della cinematografia pasoliniana insomma, la lettura di Petrolio, testimonianza postuma ignorata da troppi esegeti, avrà il sapore di un déjà vu.

