Augusto Tretti: il potere logora…
Il 19 giugno di cento anni fa nasceva Augusto Tretti. Partigiano durante la guerra, poi avvocato mancato, Tretti opta per la carriera di cineasta e si trasferisce a Roma nel momento d'oro in cui nella Capitale si poteva incontrare gente come Flaiano, Fellini e Antonioni. È proprio Antonioni a spingere Tretti a realizzare, dopo il film d'esordio La legge della tromba, l'opera seconda Il potere, che affronta il tema dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo attraverso episodi esemplari della storia dell'umanità come la preistoria, la vicenda di Tiberio Gracco, la conquista del West, il fascismo, l'età moderna. Figura ai margini del cinema italiano non per snobismo, ma per intima coerenza, vale la pena riscoprire oggi Augusto Tretti per la sua vena intelligentemente grottesca e per gli argomenti che affronta, una lezione quantomai utile anche di questi tempi. «Cineforum», sul n. 128, dicembre 1973, dedicò a Il potere un'ampia scheda, comprendente un documentatissimo articolo del direttore Sandro Zambetti e una lunga intervista a cura di Vittorio Giacci, di cui riproponiamo alcuni brani.
«Cineforum» n. 128, dicembre 1973
Scheda Il potere di Augusto Tretti
Un grottesco pensato e ragionato
Intervista con l'autore di Il potere
a cura di Vittorio Giacci
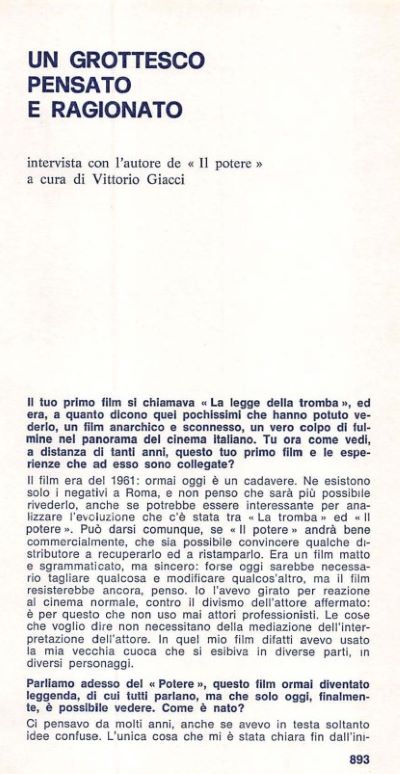 – Il tuo primo film si chiamava La legge della tromba, ed era, a quanto dicono quei pochissimi che hanno potuto vederlo, un film anarchico e sconnesso, un vero colpo di fulmine nel panorama del cinema Italiano. Tu ora come vedi, a distanza di tanti anni, questo tuo primo film e le esperienze che ad esso sono collegate?
– Il tuo primo film si chiamava La legge della tromba, ed era, a quanto dicono quei pochissimi che hanno potuto vederlo, un film anarchico e sconnesso, un vero colpo di fulmine nel panorama del cinema Italiano. Tu ora come vedi, a distanza di tanti anni, questo tuo primo film e le esperienze che ad esso sono collegate?
– Era un film matto e sgrammaticato, ma sincero: forse oggi sarebbe necessario tagliare qualcosa e modificare qualcos'altro, ma il film resisterebbe ancora, penso. Io l'avevo girato per reazione al cinema normale, contro il divismo dell'attore affermato: è per questo che non uso mai attori professionisti. Le cose che voglio dire non necessitano della mediazione dell'interpretazione dell'attore. In quel mio film difatti avevo usato la mia vecchia cuoca che si esibiva in diverse parti, in diversi personaggi.
– Parliamo adesso del Potere, questo film ormai diventato leggenda, di cui tutti parlano, ma che solo oggi, finalmente, è possibile vedere. Come è nato?
– Ci pensavo da molti anni, anche se avevo in testa soltanto idee confuse. L'unica cosa che mi è stata chiara fin dall'inizio era il titolo e l'assunto del film: una grottesca cavalcata attraverso le varie epoche della storia, per dimostrare che il potere, con abiti e mezzi diversi, è sempre lo stesso, l'oppressione e lo sfruttamento, cioè, di una classe sulle altre.
– Perché hai scelto la strada del film a tesi?
– Sono stato senz'altro influenzato da alcuni pareri negativi espressi nei confronti del mio primo film: ero stato accusato infatti di aver fatto un film intellettualistico, difficile e involuto. Anche se questo secondo me non era vero, ho comunque voluto, questa volta, data anche l'importanza del tema trattato, essere chiaro al massimo, al limite anche elementare, nella esemplificazione. Vedi ad esempio le immagini fisse, di repertorio, che ho inserito dopo la scena dell'assassinio di Tiberio Gracco: per dare l'idea della continuità della violenza di classe contro coloro che vogliono opporsi a un determinato assetto sociale, ho riportato alla memoria dello spettatore, per un attimo, i volti di Matteotti, di Gramsci, di Rosa Luxemburg, di Malcom X e di Lumumba. Qui è evidente lo scompenso del linguaggio; per un istante esco dal grottesco, per diventare serio, e il cinema diventa fotografia. C'è indubbiamente una caduta di stile, ma a questo punto non mi interessava più: è uno sforzo di umiltà, per essere il più chiaro possibile, nei punti nei quali esser chiari diventa un dovere. È stato un grande sforzo di sintesi: dire il massimo col minimo.
– Quali sono le tue aspirazioni culturali?
– Il mio cinema, senz'altro, deriva da Brecht. Brecht mi ha insegnato come dire le cose: la formula della “tesi” mi permette un effetto di “straniamento” nei confronti del pubblico; esso non si identifica più infatti nel film e nella sua trama (e in questo sarebbe stata complice anche una recitazione più impostata da parte degli attori), ma è indotto a pensare e a riflettere su quello che vede e che gli è “estraneo”. Da qui nasce appunto la necessità di attori non protagonisti, che non recitino, e la presenza della inquadratura fissa delle tre fiere come siparietto.
– È indubbia la matrice culturale di Brecht, ma sembra che tu tragga ispirazione anche dagli umori popolari della antica tradizione teatrale, quella delle giullarate ad esempio, con le quali si cercava di comunicare al popolo un determinato discorso, il più delle volte politico, contro le classi dominanti dell'epoca, volto in forma appunto non realistica e grottesca.
– Senz'altro, esistono entrambe le due componenti: l'atteggiamento popolare tipo Mistero buffo del giullare che racconta una storia comica o grottesca per dire altro, e la mediazione culturale di un Brecht, che per me è un grande maestro: bisogna seguirlo su questa strada. Mi sono sforzato di eliminare la recitazione appunto perché i miei personaggi devono sembrare marionette che raccontano un discorso che deve servire a far pensare. La recitazione straniata penso non sia facile da ottenere, ma alla fine, mi sembra anche più vera e più bella.

– Come definisci il tuo linguaggio?
– È difficile a dirsi: forse un film grottesco pensato e ragionato.
– Hai detto con molta precisione: un grottesco pensato e ragionato è la definizione più adatta al tuo film, mi pare. Il grottesco infatti è uno degli stili più difficili, perché, se non lo si sa usare, si cade inevitabilmente nel qualunquismo e nella risata liberatoria, mentre questo non succede mai nel tuo film, proprio perché il tuo senso del grottesco, non l'hai usato istintivamente e a ruota libera, ma l'hai riflettuto e ben elaborato.
– Il problema del linguaggio è alla base del film, e anche alla base, probabilmente, di tutte le traversie che esso ha avuto, più ancora per il suo contenuto. I produttori avevano paura di questo tipo di linguaggio: era un film diverso, fatto con altri canoni. Io sono convinto che molti produttori sono più contenti di perdere con un film fatto con un altro linguaggio che con un film come il mio. La scena dell'età della pietra io l'ho girata ad esempio con uno stile asciutto, ingenuo: se io fossi stato un regista “furbo”, avrei girato un episodio commerciale. Per me la provocazione politica, se fatta con un determinato linguaggio non serve a niente. Ho rovinato lo stile, come dicevo prima, in un solo punto: quando ho messo le sequenze fisse di repertorio, le fotografie dei bambini del Biafra o dei massacrati nel Vietnam, ma lì l'ho fatto non per far contento un produttore, bensì per farmi capire ancor meglio, anche se c'è qualcosa che può stridere, partendo dal presupposto che ho voluto fare questo film soprattutto per le persone che queste cose non sanno.
– Il tuo è stato definito anche come un film lirico-politico. Trovi esatta questa definizione?
– Sì, direi di sì; senz'altro nel film c'è molta passione politica, ma non è una lezione di storia: c'è tutto un aspetto lirico, che è soprattutto evidente nell'episodio del Far West: ogni indiano, prima del massacro dice una frase, guardando verso il pubblico. In quel momento non esiste più un film, ma un dialogo tra gli indiani e lo spettatore, il quale così dovrebbe sentirsi chiamato direttamente in causa: le frasi infatti sono rivolte a lui, e sono tutte, o quasi, autentiche. Ho voluto, pur nel rigore della fedeltà storica, che il pubblico provasse della tenerezza nei confronti di una popolazione, così nobile e libera, che stava per soccombere.
– Nel tuo film sembra che vi siano parecchie citazioni, parecchi richiami ai grandi maestri del cinema: la scena di Cristo al banchetto può far ricordare nella sua atmosfera generale l'analogo episodio della Via Lattea di Luis Buñuel; l'inquadratura della nave sulla quale arrivano in America i coloni, e il comandante stesso della nave, possono far pensare per un attimo al Nosferatu di Murnau, la tecnica dello straniamento rimanda immediatamente a Godard, per non parlare del carabiniere nella fabbrica durante l'episodio del fascismo, che sembra un chiaro omaggio a Charlie Chaplin.
– Per quanto riguarda Buñuel e Murnau non saprei: non ho visto i film che tu mi citi, e quindi, se vi è dell'analogia, essa è del tutto involontaria: io la chiamerei assimilazione culturale per intuito. Per quanto riguarda Chaplin invece, lì senz'altro vi è un voluto omaggio al grande comico. Questo perché come modelli della mia aspirazione, ho Brecht come insegnamento, e Chaplin come risultato artistico.
– I tre poteri (militare, finanziario, agrario) sono rappresentati come tre fiere. Perché questa scelta?
– Fin dall'inizio avevo avuto l'intuizione di rappresentare le facce del potere in maniera simbolica, ma c'è voluto un po' di tempo prima di arrivare alla soluzione degli animali feroci: prima, anzi, avevo pensato anche al cartone animato, ma mi sembra che sia senz'altro più riuscita la soluzione adottata. Le maschere che sono state realizzate dallo scultore Mario Gottardi, dovevano dar l'idea di un potere che in effetti è felino nella sua fusione di violenza, ferocia ed astuzia. Ho voluto dare allo spettatore immagini ingenue, simboliche ed immediate.
[…]
– Tutto l'episodio riguardante il fascismo, pur essendo grottesco, tocca in molti punti il sapore della realtà, in quanto quell'elemento era una componente del regime. La battaglia del grano, la marcia su Roma, D'Annunzio, il risanamento dell'agro, gli otto milioni di baionette erano in effetti dei simulacri dietro i quali si celava la realtà di un'Italia di carta. La tua sequenza del soldati, sempre gli stessi, che cambiano armi, mostrine e divise, utilizzando biciclette e cartone per confezionare cannoni e carri armati, non è molto lontana dalla realtà.
– Io ho voluto riportare nell'episodio le impressioni che avevo colto vivendo in quel periodo, e in quel periodo·il grottesco coincideva paurosamente con la realtà di tutti i giorni. I cinegiornali dell'epoca, che ci mostrano un duce trionfante che inaugura edifici e posa prime pietre, se visti oggi, ottengono un effetto comico non molto diverso dalle mie ricostruzioni. Gli avvenimenti e i dialoghi sono veri: mi sono avvalso della consulenza di uno storico, il prof. Paolo Alatri, e l'effetto che la narrazione produce è quello di una grande comicità.

– Durante la scena della marcia su Roma, in cui i quattro quadrumviri, ben riconoscibili, si muovono al passo e alle cadenze di una marcia funebre, vi è una indicazione, a parer mio, molto toccante: quella del contadino a cui i fascisti chiedono la direzione per Roma. In quella breve sequenza, sul viso del contadino passa tutta la tristezza di colui che vede dove sta andando a finire l'Italia.
– Sì. Ho voluto rendere la tristezza della classe degli sfruttati che guardano a quanto sta succedendo senza poter far nulla per impedirlo, mentre il re, in attesa fuori della Capitale, apre ai fascisti le porte della città. Un'altra indicazione di questo stato di cose ho cercato di darla nella scena dell'arruolamento nelle squadracce dell'uomo qualunque, fermo al bordo della strada, mentre passa il camion. Quell'avvenimento doveva dimostrare, in una breve sequenza, il sottoproletario disorganizzato e completamente spoliticizzato che diventa facile strumento della propaganda fascista. Nel suo sguardo buono e innocente, ho voluto indicare anche la sua assoluzione: più che un complice è una vittima.
– Per quanto riguarda la figura di Mussolini, perché gli hai voluto dare quell'aspetto così burattinesco?
– Perché Mussolini è stato in effetti un burattino, uno strumento cioè nelle mani del potere che l'ha usato finché faceva comodo, per buttarlo poi via come un oggetto divenuto inutile, nel momento in cui si rende necessario controllare la situazione con altri mezzi. Mussolini dunque è rappresentato da una maschera sormontata da un gancio di ferro, per evidenziare appunto l'aspetto di marionetta del dittatore.
[…]
– Il tuo è stato definito un film da dilettante, da “cineamatore” addirittura. Che cosa puoi rispondere in merito?
– Penso che si sia confuso tra linguaggio e contenuto: un certo tipo di linguaggio insolito, quello che io uso, ha disorientato le persone abituate a un altro costrutto filmico, e così mi hanno rimproverato, ad esempio, di non saper montare, di essere grezzo, eccetera. A me interessa sempre e comunque l'effetto che posso trarre da una situazione, anche se formalmente sgrammaticata. Se sono riuscito o meno a ottenere determinati effetti, non sta a me giudicare, comunque non mi pare affatto che Il potere sia un film superficiale o banale. Essere semplici non vuoi dire essere semplicistici, e io sono stato semplice.

